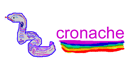Le famiglie che compongono la chimica degli oli essenziali
Le piante e i fiori e i frutti non rilasciano i loro metaboliti secondari per farci un piacere, ma per due motivi che riguardano la loro sopravvivenza, non la nostra: per attrarre fusioni amorose con i loro profumi, e con gli stessi profumi per difendersi da parassiti indesiderati. Quando andiamo a distillare, tuttavia, questi profumi eterei diventano un corpo oleoso (lasciando da parte l'idrolato, che è una fuoriuscita più acquosa; gli oli essenziali per peso vi galleggiano sopra - eccetto in alcune rarità di specie che invece li fanno affondare - quindi si estraggono con un imbuto separatore). Per nostro grande gradimento da almeno 3000 anni prima di Cristo l'essere umano sperimenta l'effetto che fa invece a lui l'uso di questi oli sulla psiche e sul corpo. Perché di questi effetti? La chimica può dare una risposta parziale, intanto perché non è detto che di un olio se ne siano trovate tutte le componenti, ma ha fatto molti studi per dare risposte a riguardo, almeno nelle componenti maggiori. Per capire di che parliamo e rendere agevole anche agli inesperti come me questa storia, umanizziamola. Diciamo che esistono delle famiglie. Che hanno le loro caratteristiche e che si trovano qua e là nelle piante e quindi negli oli, mescolate insieme, in un modo diverso a seconda della pianta. Tantissimi modi diversi. Su un fattore sono tutti al massimo all'unanimità: hanno un'altissima resistività. Ci dice uno dei pionieri della ricerca, Jean Valnet ( Aromaterapia, Giunti editore, 2006, cit. pag.372):"la loro resistività si oppone alla diffusione delle infezioni e delle tossine". Ciò che li rende tutti, in ogni caso, grandi guaritori.
Vediamo allora queste famiglie con l'aiuto di un buon libricino (Il potere curativo degli oli essenziali, di Rodolphe Balz, edito da Edizioni Il punto di incontro, 2017).
Gli idrocarburi che finiscono tutti per "ene", monoterpeni e sesquiterpeni. I monoterpeni sono composti basici di carbonio ed idrogeno in misura 10 per Carbonio e 16 per Hidrogeno.Una bilancia che può pesare in modo diverso ora da una parte ora dall'altra, creando così sottofamiglie di diterpeni, triterpeni e sesquiterpeni. Eccone alcuni: pinene, canfene, felandrene,limonene, mircene (monoterpeni); beta-cariofillene, umulene, camazolene (sesquiterpeni). I membri di questa prima famiglia non sono grandi antimicrobici ma sono decongestionanti, antispasmodici, antinfiammatori e mucolitici. Il limonene (contenutiìo in primis nella buccia del limone) può rendere non irritanti alcuni oli che contengono Aldeidi (ottimi antimicrobici e antinfiammatori, vedremo, ma anche irritanti). La deterpenazione che alcuni laboratori fanno separando gli idrocarburi dall'olio on è, quindi, sempre una buona idea (io personalmente credo mai). I sesquiterpeni sono piuttosto rari e sono grandi antinfiammatori e anche buoni antisettici. Si trovano nel sedano, nell'origano, nella camomilla.
I fenoli aromatici, grandissimi antimicrobici. Antinfettivi per eccellenza, ma potenzialmente tossici se usati in alte dosi. Anche i fenoli finiscono tutti con un unico suffisso, olo: carvacrolo, timolo, eugenolo. Si trovano nell'origano, nella santoreggia, nel timo, nella cannella.
Meno potenti dei fenoli ma anche meno irritanti, gli alcoli aromatici: linalolo, geraniolo, nerolo. Dei veri calmanti questo alcoli aromatici, oltre ad essere antinfettivi. Si trovano nella lavanda (linalolo), ma non solo. Nel geranio (geraniolo), nella menta (mentolo), nerolo (i fiori d'arancio) e ancora nella rosa, nella salvia sclarea, nel limone, nel tea tree. Essendo stimolanti naturali, favoriscono la resistenza immunitaria; il loro effetto generale è riequilibrante.
Gli ossidi aromatici non sono tanto antimicrobici ma sono antispasmodici, mucolitici ed espettoranti. Inoltre possono rafforzare le ossa e le giunture o essere analgesici. Quello più diffuso e conosciuto è 1-8 cineolo, ma ce ne sono altri. Li troviamo nell'eucalipto, ma anche nella menta, nel rosmarino.
Etere aromatico. Da buon etere è anche un buon ansiolitico o un buon sedativo. Tra i più comuni il metilcavicolo (nel basilico), il metileugenolo (nell'alloro) e il transanetolo (nell'anice e nel finocchio). Equilibranti e antispasmodici, soprattutto dei nervi, con i loro odori pungenti, come quello dei chiodi di garofano.
Altrettanto calmanti ma anche antinfiammatori efficaci sui muscoli e sul sistema nervoso gli Esteri, o i cosiddetti acetati: acetato di linalile, di bornile, cinnamico, di mentile, di eugenile. Se ne trovano a volontà: lavanda, rosmarino, pino, menta piperita, eucalipto, cipresso, elicriso, mirto, chiodi di garofano.
I cattivissimi Aldeidi. Cinnamica, citronellale, citrale. Sembrano tremendi eppure sono bene inseriti, tra la melissa, l'anice, la cannella, la nepeta cataria, l'eucalipto citriodora. Potenti antinfettivi e anche analgesici, antinfiammatorio locale, possono anche dissolvere i calcoli. Cattivi perché? Ricordate? Possono essere irritanti.
I dannatissimi chetoni, una storia a parte. Jean Valnet vedeva in loro un potere anticancerogeno. E non solo lui, le ricerche sono continuate, ma pochi lo sanno. Eppure alcuni chetoni sono stati anche demonizzati, come il tujone, contenuto nell'artemisia absinthum, oppure il carvone, il fencone (nella menta di campo). Oltre a neutralizzare e rendere innocue le cellule cancerogene, un olio essenziale che contiene un chetone è anche rigenerante. Perché tanto demonizzato? Ad alte dosi può essere neurotossico. Ma a dosi giuste i suoi effetti sono tanti: espettorante, battericida, fungicida, antiparassitario, antivirale, stimolante. Li troviamo nell'artemisia, nella salvia, nella lavanda stocheas (quella originaria), nella mentuccia, nell'elicriso, nella canfora. I chetoni, grandi guaritori delle ferite, ma anche delle febbri, un po' come Chirone.